
Anno 2012, mica poi tanto tempo fa: in quel del quartiere generale di Facebook, decidono di condurre un esperimento, utilizzando come cavie 700.000 utenti. Cavie consapevoli e volontarie per carità, per quanto lo si possa essere nel momento in cui si mette una spunta online a delle condizioni contrattuali che tipicamente nessuno legge, in cui cui si concede il diritto al social network in blu di Menlo Park di condurre questi esperimenti. Già, se siamo su Facebook, abbiamo acconsentito anche noi.
Questi (in verità quasi) 700.000 utenti sono stati salomonicamente divisi a metà e a ciascun gruppo è stato mostrato un flusso di notizie “selezionato”: in un caso venivano rimosse dal flusso le notizie più tristi e deprimenti, nell’altro quelle più allegre e spensierate. Risultato? Già, proprio quello che ci si attende: chi era esposto a maggior tristezza tendeva a condividere post più tristi e viceversa, chi era esposto a notizie più spensierate tendeva ad allinearsi con questo trend.
Ma allora siamo davvero così influenzabili?
Ad addentrarsi nel mestiere di chi realizza interfacce utente (ad esempio quelle che usiamo ogni giorno quando navighiamo su di un sito web), sembrerebbe di sì: ad esempio, in un e-commerce colori, disposizioni di elementi e contesto, sono solo alcuni dei fattori che possono notevolmente influenzare la decisione di una persona nel mettere a carrello un prodotto e successivamente procedere all’acquisto. Per chi ha voglia di approfondire un poco l’argomento, è utile leggere il racconto di come il cambio nell’aspetto e disposizione di un pulsante su di un sito web ha determinato una differenza di incasso pari a 300 milioni di dollari.
Il nostro cervello funziona per schemi e la nostra percezione della realtà segue determinati meccanismi, ben noti. Proprio sfruttando alcuni di questi meccanismi sono state create delle illusioni ottiche, tra cui alcune di grandi impatto, che ci “svelano” ad esempio come le immagini che percepiamo sono in realtà rielaborazioni (a volte anche importanti) rispetto alla realtà a noi esterna.


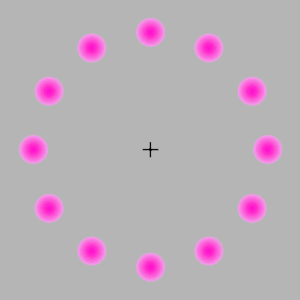
Del resto, le informazioni da elaborare sono così tante che se il nostro cervello non applicasse dei distinguo, scartandone alcune e rielaborandone altre, finiremmo per andare in corto circuito: ancorarci a delle certezze e interpretare la realtà alla luce delle stesse, è parte integrante del nostro equilibrio.
Tra queste certezze, più o meno radicate, possiamo annoverare il distinguo che facciamo tra un’opera di cui fruiamo e la pubblicità che eventualmente l’accompagna.
Guardiamo un film e ogni tanto viene interrotto da uno spot pubblicitario; ascoltiamo una canzone alla radio e al suo termine viene messo in onda uno spazio pubblicitario; sfogliamo un giornale e dopo una pagina con un articolo ne arriva un’altra con una pubblicità; guidiamo in strada ed i cartelloni segnaletici hanno certe forme, quelli pubblicitari altre.

Cosa succede però quando ad esempio l’eroe di un film indossa un determinato capo di abbigliamento o ancora, fuma una certa marca di sigarette (o comunque, fuma)?
Può questo comportamento influenzare chi vede il film, non fosse altro che per un meccanismo di emulazione? La risposta è positiva e più di un approfondimento sul tema segnala ad esempio la relazione tra le industrie del tabacco e l’industria cinematografica di Hollywood.
La scelta di trattare certi temi o ancora, di inserire in un film determinati prodotti, riconoscibili ed acquistabili sul mercato, è talmente cresciuto negli anni che ha poi portato i diversi legislatori a regolarne, seppur parzialmente, la pratica.
Una vera e propria pietra miliare del “product placement cinematografico” (è questo il nome tecnico della dinamica di cui stiamo scrivendo) dei tempi moderni, vero spartiacque rispetto al passato, è il grande classico del 1982 E.T. di Steven Spielberg: in questo film tra i protagonisti troviamo dei dolciumi della Hershey’s, preferiti agli equivalenti M&M’s in quanto quest’ultima ditta non ha voluto associare il proprio marchio al film. Le vendite di quei dolci dopo la proiezione del film si sono letteralmente impennate.
Il mercato del product placement, a riprova della sua efficacia, si è evoluto negli anni, sino a diventare un affare da svariati miliardi di dollari. Per il film “Skyfall”, il noto marchio di birra Heineken ha sborsato 45 milioni di dollari per far bere a James Bond una sua birra invece del solito Martini.

Per inciso: il product placement si va evolvendo nel digital product placement. In questo modo, grazie ad effetti digitali, la marca di cereali usata dai protagonisti in una determinata puntata può cambiare ogni volta che quella puntata viene proposta o a seconda del canale su cui viene trasmessa.
Opera e pubblicità perdono i loro così netti confini e diventa sempre più difficile distinguere quello che stiamo leggendo o vedendo per il naturale svolgersi della storia da quello che ci viene proposto per “esigenze di copione” o meglio, di sponsor.
A rendere le cose ancora più complicate ci pensa un recente film, uscito nelle sale a febbraio 2014 e che può essere considerato una nuova pietra miliare, rappresentante per eccellenza di un fenomeno che del product placement riprende determinati tratti, pur differenziandosene per altri: il native advertising.
Stiamo parlando di “The Lego Movie”, il secondo campione di incassi dei film usciti a febbraio (meglio di lui solo “La passione di Cristo” nel 2004): 69 millioni di dollari di incasso già nel primo week-end di proiezione.

Si tratta di un film in cui i mattoncini Lego sono in assoluto protagonisti e dove il posizionamento del prodotto è più che trasparente agli occhi del consumatore: diversi team della Lego hanno lavorato a stretto contatto con team della Warner Bros per portare sullo schermo una storia il più possibile avvincente, ma anche rispettosa del brand e della sua immagine pubblica. Da una parte, ad esempio, si è cercato di introdurre qualche situazione o battuta un poco più audace, per divertire anche un pubblico più adulto, ma dall’altra si è prestata molta attenzione a non creare situazioni potenzialmente inadeguate per il brand.
Il contenuto così prodotto è sicuramente di particolare interesse per il pubblico di riferimento (persone che conoscono il brand Lego e nutrono un certo favore nei suoi confronti) ma ha saputo grazie alla sua qualità andare oltre lo stessso, coinvolgendo anche chi non aveva significativa dimestichezza con il marchio. Per molti degli spettatori, si è trattato di guardare un film piacevole, indipendentemente dalle fattezze dei personaggi.
Queste caratteristiche incarnano quelle tradizionalmente attribuite alla pubblicità nativa.
Il native advertising, nella sua forma più diffusa, infatti, si può considerare così:
- un contenuto utile e interessante per il pubblico di riferimento;
- dalla provenienza dichiarata e trasparente;
- equiparabile per forme e sostanza al contenuto naturalmente proposto nel contesto di pubblicazione;
- con un legame più o meno rilevante con il brand.
In alcune definizioni il native advertising viene limitato all’online, ma le caratteristiche sopra indicate possono ben essere applicate a iniziative in qualunque ambito.
Qualche esempio ci può essere utile: si può partire da uno dei pionieri del native advertising, la testata americana Wired, sempre pronta a sperimentare ed innovare.
Di questa testata ricordiamo già anche in Italia delle iniziative particolari: ad esempio, nell’ormai lontano 2009, nel contesto di uno speciale dedicato allo sbarco sulla Luna, le pubblicità proposte erano totalmente in sintonia con il contenuto del numero, diventando un continuum particolarmente interessante e piacevole.


Questa capacità di innovare il rapporto tra contenuto e pubblicità, non è certo scemata negli anni, anzi:
in una recente esperienza di native advertising, “TV GOT BETTER”, un team editoriale di Wired ha collaborato fianco a fianco con un team di Netflix per produrre un approfondimento in stile “Snow Fall” (una tecnica di cui abbiamo scritto in un recente articolo) sui profondi cambiamenti in atto nel rapporto con i contenuti video da parte di un pubblico sempre più vasto (è un argomento importante, di cui abbiamo recentemente scritto anche noi).

In questo lunghissimo documento, Netflix contribuisce, in qualità di osservatore specializzato a chiarire il fenomeno in atto. Da nessuna parte, in tutto il documento, si dice “abbonatevi a Netflix” o “Netflix è meglio di questo o quel concorrente”. Link verso il sito di Netflix? Neanche uno.
Gli elementi di un buon native advertising ci sono tutti: il contenuto è utile ed interessante per il pubblico di riferimento e viene presentato secondo modalità a cui quest’ultimo è abituato; la sua natura di “contenuto sponsorizzato” viene ribadita più e più volte e che Netflix ne esca agli occhi dei fruitori (lettori sarebbe riduttivo vista la natura multimediale del documento) come un “protagonista della nuova televisione”, è fuor di dubbio.
Sempre Netflix ci propone un altro caso particolarmente interessante, questa volta in collaborazione con il New York Times: per promuovere la seconda stagione della serie “Orange Is The New Black” (OITNB), elabora un documento sulla vita carceraria della popolazione femminile negli Stati Uniti (sempre in tecnica Snow Fall) puntando all’attenzione ed al coinvolgimento del fruitore su di un argomento particolarmente difficile.

In questo caso un po’ più esplicitamente, in fondo al documento, si trova un banner pubblicitario che rimanda il visitatore alla scoperta della serie (che narra le vicende di una ragazza che si ritrova in carcere per crimini commessi anni addietro): il passo è davvero naturale e l’esperienza sicuramente positiva, visto che nella serie gli argomenti esposti nel documento vengono riproposti e approfonditi.
Volendolo esprimere con una metafora calcistica, si tratta davvero di un ottimo assist, perché non solo conduce la persona alla fruizione del contenuto di destinazione, ma la predispone, creando le giuste condizioni per una buona esperienza: a catena, questo porterà ad una maggiore affezione verso la serie, recensioni più favorevoli, maggiori condivisioni e tanti altri vantaggi.
(Volendo immaginare una situazione agli antipodi, prendiamo un gruppo di studenti di prima media, facciamogli saltare la ricreazione e mostriamo loro ex abrupto e senza alcuna introduzione un – pur bellissimo – film di Akira Kurosawa, per poi raccoglierne le testimonianze … !)
Una delle principali caratteristiche del native advertising è l’onestà nel rapporto con il pubblico
Un recente esperimento condotto da Contently (società di servizi che aiuta le imprese a comunicare meglio) che abbiamo trovato grazie ad uno spunto di Francesco Gavello, evidenzia come per molti non sia così chiara la natura della relazione tra le parti (fondamentalmente: “chi paga chi per fare cosa”) e che la fiducia attribuita al contenuto sponsorizzato non sia sempre così alta, anche – e soprattutto – per via di un problema di qualità, visto che molto del materiale proposto come native advertising non ne rispetta i presupposti.
Pensiamo al caso che abbiamo poco sopra citato dei 45 milioni di dollari investiti da Heineken per il product placement nel film Skyfall: se ci fosse l’obbligo di un avviso nei confronti dei consumatori di questo tipo di investimenti, ben visibile ogni volta che si sta per effettuare l’acquisto, quale sarebbe il sentimento nei confronti dei brand?
L’idea di fondo è che quando si scende nel rapporto diretto con il singolo, a nessuno piace sentirsi manipolato: alcuni prestano a questa evenienza più attenzione e altri meno, ma il gioco è davvero sottile.
Tipcamente, se la persona si rende conto “prima” di accedere ad un contenuto che questo è frutto di un investimento di un inserzionista che deliberatamente propone del contenuto finalizzato ad una certa sua agenda, potrà attivare mentalmente i giusti schermi, per valutare con più o meno adeguata consapevolezza, quanto gli viene proposto.
Se invece questa presa di coscienza avviene a posteriori, la sensazione di essere stati “ingannati” rischia di prevalere, creando più danni che beneficio per il brand.
Il ruolo del contenuto, il ruolo della distribuzione

Il native advertising è tanto più efficace quanto più il contenuto che viene prodotto “circola”, venendo apprezzato dal pubblico di riferimento e oltre. Per incentivare questa circolazione, si può ricorrere alla sponsorizzazione del contenuto attraverso diversi canali, da quelli social a quelli di content discovery come Taboola, Outbrain ed affini.
La scelta dei canali di distribuzione è importante: ciascuno ha il suo posizionamento, un certo grado di invasività nel rapporto con la naturale fruizione di contenuti da parte dell’utente, una tipicità di contenuti offerti.
La partita si gioca ormai sul mobile, che sempre di più è il primo punto di contatto con i contenuti proposti dai brand.
Lo spazio relativamente ridotto sullo schermo richiede formati adeguati. I vari “stream” ( Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, etc. ) sono il cuore di buona parte dell’esperienza mobile e richiami a contenuti di native advertising ben amalgamati con lo stream hanno ottime chanche di diventare parte naturale dell’esperienza dell’utente, senza che questi si metta a riflettere a fondo sulla provenienza degli stessi e la loro natura di contenuto a pagamento artificialmente inserito nel flusso.
Il New York Times riporta dei dati a prima vista in contrasto con quelli emersi dalla ricerca di Contently: i contenuti di native advertising proposti ai lettori del Times ottengono più o meno la stessa attenzione ed il medesimo tempo di fruizione dei contenuti tradizionali, un forte segnale di come questi siano ben recepiti da parte del pubblico di riferimento.
Si può dire che la nozione che emerge con certezza è che il potenziale dello strumento è davvero molto alto, ma altrettanto alta è l’attenzione che ci deve essere dedicata per proporre ai fruitori un’esperienza di qualità.
Il native advertising è il futuro della pubblicità?

Partiamo da un assunto: i grandi marchi stanno entrando sempre di più nelle nostre vite. Se andiamo in una città e scendiamo alla fermata “Vodafone” (non è un caso remoto: è già realtà nella vicina Spagna), se in televisione non si guarda più il Festivalbar ma il Coca Cola Music Festival o ancora, se società come Apple già tre anni fa valevano più di tutto il PIL della Svezia o le riserve auree statunitensi, siamo chiariamente di fronte ad un cambio di equilibri epocale.
A guardare questi esempi in retrospettiva, il futuro distopico immaginato da David Foster Wallace nel suo Infinite Jest, libro del 1996 in cui si narra di un mondo dove gli anni non vengono più chiamati con il loro progressivo numerico ma con l’equivalente sponsorizzazione del brand di turno (ad esempio, “l’Anno della Saponetta Dove in Formato Prova”), non sembra più così lontano.
Questa crescente presenza dei grandi marchi nel nostro quotidiano corrisponde però ad una loro significativa evoluzione ed una loro crescente attenzione agli aspetti di responsabilità sociale (in inglese Corporate Social Responsibility o come acronimo, CSR), che li rendono attentissimi ad incarnare valori comuni positivi.
Un brand come L’Oréal è velocissimo ad adottare una “instant star” come Axelle in qualità di testimonial, ed altrettanto rapido a “scaricarla” una volta che dal suo passato emergono foto non in linea con la “sensibilità comune”.
Questo delicato equilibrio che si sta delineando con sempre maggior chiarezza è un fenomeno ben lontano da quelle visioni distopiche dove i brand “dominano” la vita dei singoli, ridotti a mera fonte di profitto: si tratta invece di un ben più equilibrato rapporto di simbiosi, dove più il brand ha imparato che per crescere deve affiancare al profitto obiettivi di crescita del bene comune, nelle sue diverse forme (benessere, felicità, crescita, etc.), più ha chance di ottenere il favore del pubblico.
Il native advertising, nelle sue espressioni di maggior qualità, si innesta in questo trend e diventa un ulteriore punto di contatto, un’altra occasione per fare la differenza, in positivo, nella vita delle persone. Per certi versi, è più efficace di altri strumenti, per altri meno: il suo impiego è quindi da soppesare con attenzione, nel contesto di un piano marketing dal più ampio respiro.

Per renderci conto del ruolo che le grandi aziende stanno assumendo nella società moderna, riprendiamo un esempio dal campo dell’esplorazione spaziale: realtà private come SpaceX hanno dimostrato un’efficienza di gran lunga superiore a realtà pubbliche come la N.A.S.A. e se nel 1969 lo sbarco sulla Luna fu un’impresa di stato, non è da escludere che le prime missioni umane su Marte potrebbero essere figlie dell’iniziativa imprenditoriale di aziende come SpaceX e simili, con anni di anticipo rispetto alle equivalenti missioni statali.
Se la bandiera che verrà piantata sul pianeta rosso sarà quella di un’azienda e non più – esclusivamente – quella di una nazione, si avrà il suggello definitivo ad un importante cambiamento in atto di cui il native advertising è solo uno dei tanti – importanti – segnali.



